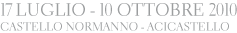Parlare del bello e di Nuovo Rinascimento in un epoca digitale come è quella che stiamo vivendo vuol dire provare, dunque, ad interrogare il mondo che ci circonda, tenendo presente che una delle caratteristiche di un’estetica mutante, come è quella che stiamo cercando e che tenteremo di descrivere, è quella di avere delle caratteristiche che sembrano classiche, standard, che ben si attanagliano ad un estetica borghese storica della middle-class e, improvvisamente, vedere il loro cambiamento, assistere ad un paesaggio che muta, come in un dispositivo onirico e mentale.
Ad esempio, con l’avanzare dei Secondi Mondi Virtuali Condivisi il concetto di bellezza che troviamo in mondi come Second Life, per gli avatar, è quello di una bellezza stereotipata, tarata sull’estetica californiana Wasp, simile alle immagini dei videoclip e di MTV ma possiamo anche trovare i Furry, cioè avatar digitali in parte umani e in parte animali che potrebbero ricordare, molto da vicino, gli animali mitologici e gli ibridi come le chimere, descritti da poeti, artisti, scultori nel corso degli ultimi secoli.